L’insegnamento della religione in Italia e in Europa
13 Agosto 2009
Se un merito occorre riconoscere alla sentenza del Tar del Lazio riguardo alla funzione e al ruolo dell’IRC (= insegnamento della religione cattolica) nell’ordinamento della scuola italiana, è, oltre all’argomentazione propriamente logico-giuridica con cui viene dimostrata la incompatibilità fra tale insegnamento e la valutazione scolastica, quello di promuovere e stimolare, in un paese che sembra cloroformizzato dai pregiudizi, dalla misologia e dal filisteismo, un dibattito più ampio non solo sul suo significato educativo e culturale, ma anche, e soprattutto, sul rapporto tra il principio della laicità, che è uno dei fondamenti dello Stato di diritto, e il modo in cui viene insegnata la religione.
Per poter dare un contributo non meramente impressionistico al dibattito è però necessario chiarire il quadro legislativo italiano e confrontarlo con gli ordinamenti scolastici di alcuni paesi europei. Risale, infatti, al ministro dell’Istruzione Moratti quella legge per l’assunzione in ruolo dei docenti di religione cattolica che, all’inizio di questo decennio, ha riaperto l’annoso problema della difficile gestione legislativa delle norme pattizie previste dai concordati tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede. In questo caso, che forma oggetto della sentenza emessa dal Tar del Lazio, la questione è tanto più delicata in quanto chiama in causa un principio costituzionale di eguaglianza di tutti i cittadini davanti allo Stato e alla sue leggi, a prescindere dalle loro convinzioni religiose. Eguaglianza che evidentemente non può essere rispettata per un insegnamento per il quale si chiede non tanto competenza quanto un’adesione ideale ed etica.
Alla complicazione costituzionale si aggiunge poi una complicazione giuridica, dal momento che la legge prescrive l’assunzione per pubblico concorso, mentre la nomina dei docenti di religione avviene ‘de jure’ e ‘de facto’ ad opera dell’autorità diocesana, che certo pubblica non è. E all’autorità diocesana compete non solo il potere di indicare colui che è nominabile, ma anche il potere di destituirlo nel caso in cui non dovesse più rispondere non tanto all’occorrenza materiale, quanto, soprattutto, alla coerenza morale ed ideale che gli è imposta. Insomma, l’autorità ecclesiastica ha un potere più forte e meno garantista della stessa autorità pubblica, che non può certo destituire un suo dipendente in base ad un cambiamento di idee dello stesso e che, quando deve procedere alla destituzione anche per giustificati motivi, prevede tutta una serie di garanzie per il lavoratore. In effetti, se l’autorità ecclesiastica può destituire per un cambiamento di opinione e quella pubblica no, è inevitabile (come è successo già in alcuni casi) che lo Stato dovrà comunque accollarsi l’insegnante di religione che cambia idea, utilizzandolo in altri insegnamenti. A questo punto, se si pensa che questo si aggiunge alla possibilità del passaggio di cattedra e di ruolo una volta in servizio, è evidente che il passaggio attraverso l’IRC rappresenta un modo per aggirare le normali procedure di reclutamento per le altre materie.
Se si prende poi in considerazione il quadro legislativo europeo, si può notare che, oltre alla Spagna che ha recentemente abolito il carattere obbligatorio dell’IRC e ha posto tale insegnamento sullo stesso piano delle altre confessioni religiose con cui lo Stato ha sottoscritto accordi, solo la Francia mantiene un atteggiamento rigorosamente laico. Nelle scuole statali francesi non si insegna religione né si esibiscono simboli di carattere religioso. Si insegna solo nelle scuole private (circa il 20% delle scuole francesi, di cui il 90% sono scuole cattoliche), le quali in buona parte sono sovvenzionate dallo Stato, che retribuisce i docenti , ma solo quelli delle materie ufficiali e quindi non gli insegnanti di religione. Da più parti si propone anche di inserire lo studio di storia delle religioni, ma si teme che, se la Chiesa cattolica cercherà di gestire in proprio tale insegnamento, la numerosa comunità islamica francese vorrà fare lo stesso da parte sua.
La Germania, ad esempio, è proprio agli antipodi del caso italiano. Qui sono previste due ore di religione alla settimana. Ma queste possono riguardare ben cinque religioni: la cattolica, la evangelica, l’ortodossa, la neoapostolica e l’ebraica. E per chi è esonerato ci sono lezioni di “etica”. Qui tutto dipende dalle leggi regionali e dagli accordi tra comunità religiose e ‘Länder’. Quel che è certo è che l’insegnamento è assolutamente “statale”, senza alcuna ingerenza dell’autorità ecclesiastica. Per insegnare occorre essere laureati in teologia o in religione, come per qualunque altra materia. Per inciso, giova ricordare che “il rosso” Rudi Dutschke, studente di teologia nel Sessantotto berlinese, era negli anni settanta proprio un insegnante di religione evangelica. Allo stesso modo, per insegnare come materia alternativa “etica” è necessario essere laureati in filosofia o in sociologia.
Altri Stati europei, come il Regno Unito o i Paesi Bassi, sfuggono alla possibilità di stabilire analogie col caso italiano per motivi diametralmente opposti a quello tedesco: qui il modello privatistico, da un lato, e la compresenza di religioni diverse (cattolici, anglicani, evangelici), dall’altro, stemperano gli aspetti giuridici del problema nella separazione delle scuole e quelli ideologici in un sincretismo tra le tre confessioni cristiane. I Paesi Bassi sono il paese della libertà religiosa per antonomasia. Essa affonda le sue radici nella costituzione del 1848, che permette a tutti di istituire proprie scuole. Tre quarti delle scuole sono private e un quarto è formato da scuole comunali. Formalmente a scuola non viene impartito l’insegnamento della religione, ma la materia di “etica”, che comprende nozioni di tipo religioso, e i docenti di etica sono assunti come tutti gli altri, mentre nelle scuole confessionali si ricorre a sacerdoti, pastori e imàm, spesso non qualificati, e queste ore di etica sono insegnate secondo la fede che è propria di ogni religioso. Qualcosa di analogo succede in Gran Bretagna. Qui addirittura le scuole religiose sono considerate a tutti gli effetti statali. L’insegnamento della religione è obbligatorio dai 5 ai 16 anni, rientra nel curricolo nazionale, ma non comporta promozione o bocciatura né il governo impone un programma. Non sono previste attività alternative, ma solo la vigilanza degli alunni. Gli insegnanti devono venire dalle facoltà di scienze della formazione, come tutti gli altri insegnanti, e come tutti hanno contratti locali o di scuola. In entrambi questi casi i problemi del rapporto con un’autorità religiosa si pongono solo nelle scuole dipendenti da una di queste.Manco a dirlo apposta, il paese che riproduce la situazione più simile a quella italiana è, dopo la integrale laicizzazione attuata in Ispagna, il Portogallo. Quest’ultimo ha introdotto una normativa in base alla quale l’IRC fa parte dell’area opzionale insieme con altri insegnamenti. In quanto tale, la frequenza non è obbligatoria, anzi di norma la lezione deve essere collocata alla fine dell’orario scolastico: il che ha però suscitato la contrarietà della Conferenza episcopale portoghese, preoccupata anche dallo scarto di frequenza alle lezioni tra primaria (80%) e secondaria (50%). La protesta della Conferenza episcopale ha posto rilevanti problemi, perché la base legislativa fondamentale della materia è ancora il Concordato siglato dal regime salazarista nel 1940. Dopo la ‘Rivoluzione dei garofani’ era stata introdotta come materia alternativa una specie di educazione civica denominata “Sviluppo della società e della persona”, ma non si riusciva a coprirla: così, per non avere ore buche, gli esonerati dovevano o fare religione o sperare che la lezione cadesse all’ultima ora. Il Portogallo prevede per gli insegnanti di religione il medesimo trattamento previsto per gli altri docenti. Se si eccettuano Stati di tipo integralista come la cattolica Polonia, l’Italia e il Portogallo sono gli unici paesi in Europa, ove il reclutamento degli insegnanti di religione avviene attraverso una nominadell’insegnante fatta su proposta dell’autorità ecclesiastica.
Altri Stati europei, come il Regno Unito o i Paesi Bassi, sfuggono alla possibilità di stabilire analogie col caso italiano per motivi diametralmente opposti a quello tedesco: qui il modello privatistico, da un lato, e la compresenza di religioni diverse (cattolici, anglicani, evangelici), dall’altro, stemperano gli aspetti giuridici del problema nella separazione delle scuole e quelli ideologici in un sincretismo tra le tre confessioni cristiane. I Paesi Bassi sono il paese della libertà religiosa per antonomasia. Essa affonda le sue radici nella costituzione del 1848, che permette a tutti di istituire proprie scuole. Tre quarti delle scuole sono private e un quarto è formato da scuole comunali. Formalmente a scuola non viene impartito l’insegnamento della religione, ma la materia di “etica”, che comprende nozioni di tipo religioso, e i docenti di etica sono assunti come tutti gli altri, mentre nelle scuole confessionali si ricorre a sacerdoti, pastori e imàm, spesso non qualificati, e queste ore di etica sono insegnate secondo la fede che è propria di ogni religioso. Qualcosa di analogo succede in Gran Bretagna. Qui addirittura le scuole religiose sono considerate a tutti gli effetti statali. L’insegnamento della religione è obbligatorio dai 5 ai 16 anni, rientra nel curricolo nazionale, ma non comporta promozione o bocciatura né il governo impone un programma. Non sono previste attività alternative, ma solo la vigilanza degli alunni. Gli insegnanti devono venire dalle facoltà di scienze della formazione, come tutti gli altri insegnanti, e come tutti hanno contratti locali o di scuola. In entrambi questi casi i problemi del rapporto con un’autorità religiosa si pongono solo nelle scuole dipendenti da una di queste.Manco a dirlo apposta, il paese che riproduce la situazione più simile a quella italiana è, dopo la integrale laicizzazione attuata in Ispagna, il Portogallo. Quest’ultimo ha introdotto una normativa in base alla quale l’IRC fa parte dell’area opzionale insieme con altri insegnamenti. In quanto tale, la frequenza non è obbligatoria, anzi di norma la lezione deve essere collocata alla fine dell’orario scolastico: il che ha però suscitato la contrarietà della Conferenza episcopale portoghese, preoccupata anche dallo scarto di frequenza alle lezioni tra primaria (80%) e secondaria (50%). La protesta della Conferenza episcopale ha posto rilevanti problemi, perché la base legislativa fondamentale della materia è ancora il Concordato siglato dal regime salazarista nel 1940. Dopo la ‘Rivoluzione dei garofani’ era stata introdotta come materia alternativa una specie di educazione civica denominata “Sviluppo della società e della persona”, ma non si riusciva a coprirla: così, per non avere ore buche, gli esonerati dovevano o fare religione o sperare che la lezione cadesse all’ultima ora. Il Portogallo prevede per gli insegnanti di religione il medesimo trattamento previsto per gli altri docenti. Se si eccettuano Stati di tipo integralista come la cattolica Polonia, l’Italia e il Portogallo sono gli unici paesi in Europa, ove il reclutamento degli insegnanti di religione avviene attraverso una nominadell’insegnante fatta su proposta dell’autorità ecclesiastica.
In conclusione, pur in presenza di una larga diffusione dell’insegnamento della religione nelle scuole europee, non si può dire che il problema dell’intreccio tra legislazione di carattere pubblico e norme pattizie sia facilmente risolvibile. Ma se una soluzione vi è, come dimostrano sia il caso francese sia i casi tedesco, inglese e olandese, questa, come ancora una volta ha sottolineato con lucidità e rigore la magistratura, non può essere perseguita a spese del diritto pubblico e dell’inderogabile principio della eguaglianza di tutti i cittadini davanti allo Stato e alla sue leggi, a prescindere dalle loro convinzioni religiose.


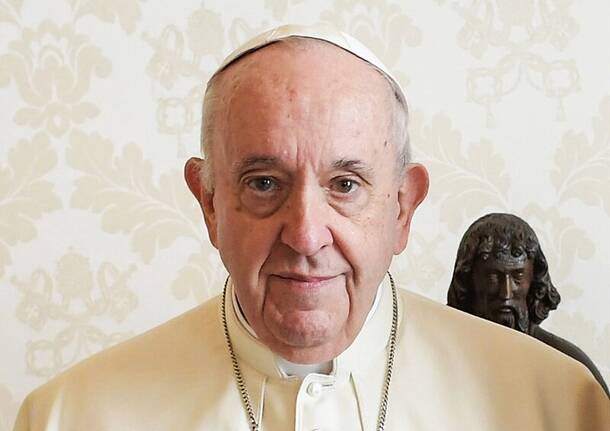




Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.