Leggi borboniche
7 Maggio 2009
Egregio Signor Direttore,
oggi, allorquando in Italia qualcosa nella pubblica amministrazione o nella macchina dello Stato non va, se una legge appare ingiusta, meschina, pignola, tormentatrice del cittadino, chi scrive su riviste o quotidiani se ne viene fuori con il luogo comune: “leggi borboniche”, dando a questa dizione un significato negativo a trecentosessanta gradi.
Ebbene, è giunto il momento di sfatare questa leggenda, peraltro calunniosa nei confronti del
legislatore dell’ex Regno delle Due Sicilie, oltre che per noi meridionali stessi.
A distanza di un secolo e mezzo dall’annessione del Meridione d’Italia al Piemonte, è possibile affermare, con cognizione di causa, che le leggi napoletane erano ottime, tanto che, nel 1852,
Napoleone III inviò a Napoli una speciale commissione di giuristi ed alti funzionari, perché studiassero la bontà di quelle leggi, che da un pezzo vietavano la tortura giudiziaria (quando nel Piemonte essa vigeva ancora con tutta la sua ferocia), stabilivano che la corrispondenza privata non venisse in alcun modo manomessa, che non fosse lecito imprigionare un povero debitore senza un giudizio di merito che stabilisse la frode, e via dicendo. A titolo esemplificativo, menzionerò tre normative “borboniche” che, come si vedrà, sono peraltro attualissime: la prima in materia economico-sociale, la seconda sull’
immigrazione, la terza in materia di igiene pubblica e raccolta dei rifiuti.
Materia economico-sociale. Nel 1789, il re Ferdinando IV (poi I) di Borbone emanò il Codice-statuto delle Seterie di San Leucio, presso Caserta, per regolamentarvi la vita ed il lavoro degli operai e dei loro nuclei familiari. La colonia di San Leucio fu un progetto ideato e voluto dallo stesso re. L’opificio, conosciuto poi in tutta Europa per l’elevato livello tecnologico ed i cui pregiati manufatti
venivano largamente esportati, divenne il “fiore all’occhiello” dell’ industria del Sud. Si trattò di un vero e proprio “miracolo” (non solo sotto il profilo economico, ma anche sotto l’aspetto sociale), che
stupì i contemporanei, realizzato sulla base delle teorie socio- economiche dell’illuminista Gaetano Filangieri. Il Codice Leuciano, ben presto tradotto in greco, francese e tedesco, anticipò di quasi un
secolo le prime leggi sul lavoro varate in Inghilterra (previdenza, assistenza, case ai lavoratori, asili nido, istruzione elementare obbligatoria e gratuita per i fanciulli). Esso perseguiva, infatti,
obiettivi di convivenza tipicamente moderni e mirava a realizzare una sorta di “socialismo evangelico”: sanciva, per i componenti della colonia, la perfetta uguaglianza, con l’unica possibilità di
differenziazione basata sul merito. Le coppie giovani avevano diritto di prelazione per sistemarsi. Fu così costruito un vero e proprio stabilimento di moderna concezione, che richiamò gente da fuori e
famiglie intere in cerca di lavoro e reddito garantito. Lo statuto prevedeva un criterio retributivo, certamente parsimonioso, però in anticipo sui tempi, ed una specie di piano contro il pauperismo del
Sud; perché l’iniziativa «dev’essere – sono parole del re Ferdinando – utile alle famiglie, alleviandole da’ pesi, che ora soffrono, e portandole ad uno stato tale da potersi mantener con agio, e senza
pianger miseria, come finora è accaduto in molte delle più numerose e oziose». Tessuti finissimi, stoffe damascate, lampassi preziosi uscirono per decenni dalle fabbriche leuciane e ben due terzi della
produzione totale erano destinati all’esportazione verso gli Stati Uniti d’America.
Immigrazione. La legge emanata il 17 dicembre 1817 dal re Ferdinando I di Borbone, cui seguì il decreto n. 10406 del 19 ottobre 1846 del re Ferdinando II, regolamentava la concessione
della cittadinanza agli stranieri. Essa, composta da soli tre articoli, fu la prima normativa della storia sull’immigrazione; il suo “principio informatore” era quello secondo cui, per poter acquisire la
cittadinanza nel regno, uno straniero doveva risultare concretamente utile alla collettività ed, in nessun caso, poteva costituire un problema sociale od un peso economico per lo Stato. In particolare, all’
articolo 1, così recitava: «Potranno essere ammessi al beneficio della naturalizzazione nel nostro regno delle Due Sicilie: 1. gli stranieri che hanno renduto, o renderanno importanti servizi allo Stato; 2.
quelli che porteranno dentro lo Stato de’ talenti distinti, delle invenzioni, o delle industrie utili; 3. quelli che avranno acquistato nel regno beni stabili su’ quali graviti un peso fondiario almeno di
ducati cento all’anno; al requisito indicato ne’ suddetti numeri 1, 2, 3 debbe accoppiarsi l’altro del domicilio nel territorio del regno almeno per un anno consecutivo; 4. quelli che abbiano avuto la
residenza nel regno per dieci anni consecutivi, e che provino avere onesti mezzi di sussistenza; o che vi abbiano avuta la residenza per cinque anni consecutivi, avendo sposata una nazionale». Questa legge è la prova che, prima dell’unità d’Italia, non solo i meridionali non conoscevano il triste fenomeno dell’emigrazione, ma che numerosi erano i casi di emigranti, dall’Italia settentrionale e dal resto del mondo, che venivano a stabilirsi al Sud. Ci è dato, infatti, di sapere che il Regno delle Due Sicilie era meta ambita da svizzeri, piemontesi, genovesi, russi, austriaci, spagnoli, arabi, slavi e, soprattutto,
francesi ed inglesi. Tali flussi migratori verso il nostro Sud forniscono, inoltre, un dato inequivocabile: lo Stato meridionale era ricco e felice, vi era pace sociale e lavoro. La differenza di cultura,
di religione e di lingua non erano motivi di discriminazione né, tanto meno, di emarginazione. In sostanza, la legislazione del Regno delle Due Sicilie, in materia di concessione della cittadinanza agli
stranieri ed ai loro figli, era avanti, rispetto a quella attualmente in vigore nello Stato Italiano (ad iniziare dalla legge del 5 febbraio 1992, n. 91), di ben centosettantacinque anni!
Igiene pubblica e raccolta dei rifiuti. Un decreto emanato il 3 maggio 1832 dal re Ferdinando II di Borbone, analizzava e regolamentava l’intera situazione igienica dei rifiuti napoletani. Inoltre, un’ordinanza della prefettura di polizia disciplinava, nei dettagli, lo spazzamento e l’
innaffiamento delle strade, compresa una sorta di “raccolta differenziata” per il vetro. A Napoli, il prefetto dell’epoca, Gennaro Piscopo, ordinò ai napoletani: «Tutt’i possessori, o fittuarj di case,
di botteghe, di giardini, di cortili, e di posti fissi, o volanti, avranno l’obbligo di far ispazzare la estensione di strada corrispondente al davanti della rispettiva abitazione, bottega,
cortile, e per lo sporto non minore di palmi dieci di stanza dal muro, o dal posto rispettivo. Questo spazzamento dovrà essere eseguito in ciascuna mattina prima dello spuntar del sole, usando l’avvertenza di ammonticchiarsi le immondizie al lato delle rispettive abitazioni, e di
separarne tutt’i frantumi di cristallo, o di vetro che si troveranno, riponendoli in un cumulo a parte». Nel dettagliato documento del prefetto, composto da 12 articoli, venivano indicate le modalità della
raccolta e chi ne era responsabile; si vietava di gettare dai balconi materiali di qualsiasi natura, comprese le acque utilizzate per i bagni, e di lavare o di stendere i panni lungo le strade abitate;
venivano, infine, stabilite le pene per le contravvenzioni, non esclusa la detenzione. Questa “legge borbonica” aveva già risolto il problema della spazzatura quasi duecento anni or sono, rendendo Napoli la città più pulita d’Europa.
Accanto a questi veri e propri primati, sempre in campo giuridico e normativo, è doveroso quantomeno menzionare l’introduzione (fra le norme di diritto processuale) dell’istituto della
Motivazione delle Sentenze, avvenuta nel 1774 sempre sulla base delle teorie illuministe del Filangieri; il primo Codice Marittimo del mondo, datato 1781, la cui stesura fu opera di Michele Iorio; il primo Codice Militare d’Italia promulgato nel 1820; nonché la Prammatica del 20 settembre 1836, di Ferdinando II, sul demanio e sugli usi civici, dal cui testo emerge chiaramente una caratteristica tipica del Diritto napoletano: la salvaguardia dei diritti dei più deboli rispetto a
quelli dei più forti. Ecco, Signor Direttore, quale è stato il prezioso lascito che noi meridionali abbiamo ricevuto in eredità dalla struttura statale e dalle leggi su cui si reggeva il regno borbonico:
la consapevolezza e l’orgoglio di essere i discendenti e gli eredi di un popolo civile, laborioso, prospero e pacifico (mai aggressore, ma sempre aggredito!). Le sue leggi, semplici ed efficacissime,
affondavano le radici nella culla del vero Diritto e, soprattutto, nella legge perfetta: la costituzione universale di Dio, il Vangelo.
Anche se “laico”, quel regno aveva alla base gli elementi portanti di uno “stato di amore” fatto di tolleranza, mutuo soccorso ed equità sociale, propri del Messaggio di Gesù Cristo. Certamente fu questa una delle peculiarità che decretarono la condanna morte del Regno delle Due
Sicilie, in un mondo dove le potenze ateo-massoniche stavano per sferrare la più vile e potente delle aggressioni agli antichi Stati cattolici d’Europa.




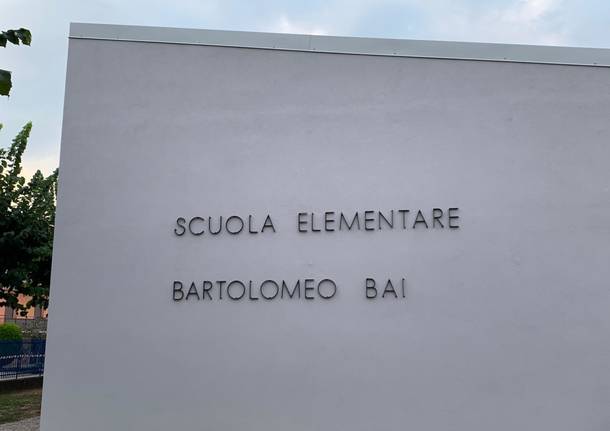


Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.