A che cosa serve ricordare la ‘grande guerra’?
3 Novembre 2008
Egregio direttore,
provo sempre un sentimento particolare nel ripensare alla ‘grande guerra’ del 1915-1918, a un passato che si allontana sempre di più, a immagini che diventano nella memoria sempre più sbiadite, anche se sono dotate di una profonda forza di suggestione. Stiamo assistendo, infatti, alla scomparsa degli ultimi testimoni, nel caso italiano i “Cavalieri di Vittorio Veneto”, e questa è una perdita che chiunque sia stato vicino alla memoria di quell’evento avverte ancora, come accade agli uomini della mia generazione che hanno appreso le vicende concrete di quella guerra dai propri nonni e hanno ancora potuto vedere, fra anni ’50 e anni ’60 del secolo scorso, soprattutto nei paesi e nei piccoli centri dove era più facile e più frequente osservarlo, l’impressionante spettacolo dei mutilati di guerra: tronchi umani dolenti senza gambe, senza mani, senza vista…
La scomparsa dei testimoni diretti, dei soldati che combatterono e vissero quella guerra, coincide perciò con lo stemperarsi, inevitabile, di quello che per me, ragazzino di nove, dieci anni, fu, nella società italiana di allora, un trauma emotivo e cognitivo. Un trauma riproposto, ad ogni piè sospinto, dai simboli, dai ricordi, dai reperti, dalle testimonianze e dai testimoni della guerra. L’eco di quella guerra si avvertiva nettamente nella memoria di tutti, nella scuola, nei maestri e nelle maestre, e si fece ancora più forte in occasione delle celebrazioni che si svolsero in occasione del primo centenario dell’Unità d’Italia (1961). In tutti era ancor vivo, che so?, il ricordo della ‘Strafexpedition’, “la spedizione punitiva contro l’alleato fedìfrago”, il ricordo mitologico della ‘Grosse Berthe’, il supercannone dislocato contro gli italiani, che possedeva un privilegio fortissimo dal punto di vista della memoria di quegli eventi. Del resto, uno degli aspetti più spaventosi di quel conflitto fu la guerra delle mine, con i cunicoli scavati da austriaci e italiani per far saltare la postazione nemica (un’azione più simile al terrorismo che al confronto leale ‘uomo contro uomo’, ‘plotone contro plotone’).
Né posso dimenticare l’emozione fortissima, il ‘sacro terrore’ che ho provato di fronte ai cimiteri di guerra, come quello che ebbi modo di visitare qualche anno fa a Lavarone, in provincia di Trento, dove riposano i caduti austriaci provenienti dalla periferia dell’Impero austro-ungarico, identici ai nostri contadini provenienti dal Sud d’Italia, che insieme formarono le grandi masse che furono gettate, come carne da cannone, in quell’immane conflitto. Orbene, non vi è dubbio che nel passato l’immagine della guerra ha contribuito a definire l’identità della nazione e ha avuto un ruolo potentissimo nella politica, riversandosi nei sussidiari, nelle scuole, nelle cerimonie politiche, nel nostro stesso rapporto con le Forze Armate.
La domanda che sorge di getto è allora la seguente: resta qualcosa di tutto questo? Se noi pensiamo che il nostro paese ha attraversato nel corso del Novecento crisi profondissime: la crisi che siamo abituati ad associare all’avvento del fascismo (28 ottobre 1922), al crollo della nazione (8 settembre 1943), alla stesso terremoto politico dei primi anni Novanta del secolo scorso (“crisi della Repubblica e dei partiti”, per usare la definizione di Pietro Scoppola), possiamo affermare, alla luce di queste esperienze collettive, che si dia, nel corso del Novecento, una continuità che ci permette di riconoscerci come italiani?
In realtà, dobbiamo riconoscere le fratture che si sono verificate, le fratture che abbiamo vissuto e di cui abbiamo memoria. E dobbiamo compiere questa operazione, che è ad un tempo cognitiva ed etico-politica, sapendo che né la retorica né il cinismo costituiscono risposte adeguate all’importanza di questa domanda. D’altra parte, come ha osservato Zygmunt Baumann, la parola ‘identità’ viene evocata spesso proprio quando la comunità crolla. Ma se dobbiamo provare a ricostruire una storia, quella di chi ci ha preceduto e quella in cui siamo collocati, perché non ci sia soltanto una storia di frammenti e di processi interrotti, dobbiamo essere in grado di ripensare alla ‘grande guerra’ anche per i problemi che si pongono oggi, e il problema fondamentale, oggi come allora, il problema su cui si gioca il futuro di una grande nazione democratica come l’Italia, è quello del dualismo fra Nord e Sud. Se un motivo di riflessione sulla nostra identità di nazione ci viene imposto dalla rievocazione della ‘grande guerra’ in relazione al presente e al futuro del nostro paese, questo, ne sono convinto, è il problema del dualismo fra Nord e Sud e del modo in cui può essere superato. Questo ci chiede, in primo luogo, la memoria di quella guerra, con tutto ciò che l’ha preceduta e seguìta. Quei 600.000 morti non saranno morti invano, se (e solo se) le forze sane del nostro paese sapranno affrontare e risolvere questo problema.




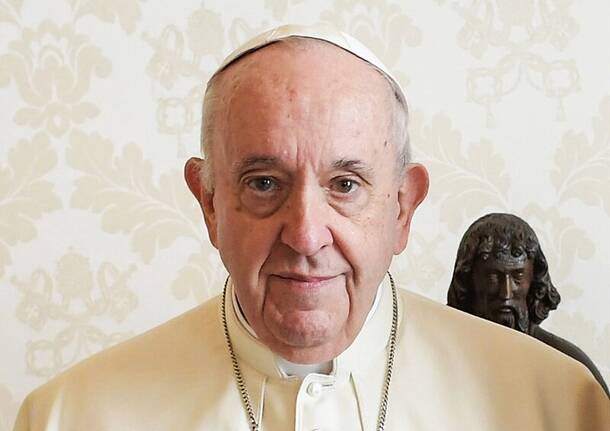


Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.