Chi si può permettere la ricerca?
Tutti riconoscono e dichiarano che l’Italia ha bisogno di ricerca e sviluppo per superare la crisi del proprio sistema imprenditoriale, crisi che potrebbe non essere transitoria ma definitiva e di struttura. Abbiamo infatti visto che con l’affacciarsi alla produzione industriale da parte dei paesi emergenti che si avvalgono di moderne tecnologie e che manifestano determinazione gestionale e bassi costi di manodopera, noi non possiamo competere sul prezzo, ma solo sul tipo e sulla qualità di prodotti.
Dobbiamo allora confrontarci con parametri diversi, puntando sulle caratteristiche del prodotto, della produzione, della distribuzione e tendendo al loro miglioramento.
Di solito questi risultati si ottengono studiando i problemi e ricercando le soluzioni. Facendo cioè lavoro di ricerca e sviluppo.
V’è una distinzione fra la ricerca e lo sviluppo: la ricerca, cosiddetta di base, non ha una finalità specifica se non di indagare materiali e fenomeni alla ricerca di una migliore comprensione delle leggi fisiche da cui possano scaturire nuovi materiali o nuovi modi di impiego di materiali; lo sviluppo, anche detto ricerca applicata, è inteso a realizzare o migliorare un prodotto o un processo produttivo.
Chi può fare ricerca pura? Chi se la può permettere? Solo le università, le istituzioni nazionali o sopranazionali, le grandi imprese. Perché la durata della ricerca pura è lunga e gli esiti non sono certi, perché essa è costosa, perché, nella complessità ormai raggiunta dalla scienza, ci vuole un gruppo interdisciplinare di ricercatori. Eppure sono i risultati della ricerca pura che fanno fare progressi alla scienza e che arricchiscono le imprese e le nazioni.
La ricerca universitaria è finanziata dal Ministero competente e da contribuzioni di imprese. Il guaio è che per la ricerca pura si può ben tenere conto di quanti fondi vengono erogati, ma è difficile misurarne l’efficienza. Il vero metro della validità dei risultati è nei brevetti e nei riconoscimenti internazionali, nei premi Nobel attribuiti ai nostri ricercatori scientifici. Degli 8 premi Nobel scientifici assegnati nel dopoguerra ad italiani, solo due si riferiscono a ricerche svolte in Italia: Giulio Natta del Politecnico di Milano per la scoperta del polipropilene isotattico (la Montecatini con questo brevetto fece una fortuna sul Moplen) e Daniel Bovet, cittadino svizzero, formatosi scientificamente all’Istituto Pasteur di Parigi ma dal 1947 operante all’Istituto Superiore della Sanità a Roma e dal 1948 cittadino italiano. Per il resto le ricerche sono sempre state condotte presso istituti esteri. E non mi risulta che premi Nobel siano stati assegnati a ricercatori stranieri per ricerche svolte presso istituti italiani. C’è evidentemente qualcosa che non va.
La ricerca applicata è più diffusa, e si può pensare che sia svolta da ogni impresa che tenda a migliorare i propri risultati. La fanno le grandi imprese, e la fanno le piccole imprese. Abbiamo leggi che assegnano contributi alle piccole e medie imprese per incoraggiare l’innovazione, ma non si tratta di contributi determinanti. Parlavo con l’amministratore di una filatura del Biellese, che mi diceva avevano usufruito solo di un contributo per ricerche di preparazione del loro campionario, e null’altro. Perché? Perché si trattava di contributi non significativi e di laborioso ottenimento. D’altronde quando una ricerca applicata è utile e l’imprenditore ne è convinto, la svolge anche senza contributi, e il mercato lo rimunera rapidamente.
Vi sono anche incentivi fiscali. La legge finanziaria 2005 appena varata prevede che il costo del personale destinato alla ricerca e allo sviluppo non sia assoggettato all’IRAP, quindi su quel costo l’imprenditore risparmierà il 4,2% di imposta. Non mi pare infine un incoraggiamento così determinante. C’è un vecchio detto pugliese secondo cui ogni pietra alza parete, quindi nel compilare una dichiarazione fiscale terrò conto delle facilitazioni fiscali esistenti, e se possibile farò risparmiare l’IRAP sul costo del personale che potrà essere considerato dedicato alla ricerca; ma se ci aspettiamo da questo uno stimolo significativo alla competitività delle imprese italiane, avremo grosse delusioni.
Il problema della competitività è all’ordine del giorno in tutta Europa, e penso all’intervento del 29 gennaio scorso, al Forum Economico Mondiale riunitosi a Davos, del presidente della Commissione europea José Manuel Barroso per rilanciare il piano europeo di competitività e all’agenda di Lisbona. Ma tutto sembra poi diluirsi giù per li rami, fino al problema del singolo imprenditore di produrre ricchezza e superare crisi e concorrenza.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Giuseppe Mantica su Un futuro nella musica per il cardiologo dell’ospedale di Gallarate Giovanni Gaudio in pensione a fine anno
Felice su Il pericoloso gioco alla stazione Ferno-Lonate: ragazzini attraversano i binari nel tunnel
lenny54 su È arrivato il gran giorno a Monteviasco: dopo sette anni di stop riparte la funivia
Adriana Andriani su Bogno, la Fondazione Sacro Cuore in liquidazione. Bini: "Non c'erano le condizioni economiche per proseguire"
Bruno Paolillo su Ottant’anni fa Hiroshima: la memoria della bomba che cambiò il mondo
PaoloFilterfree su Vigili del fuoco, organico solo sulla carta: Candiani denuncia l’abuso delle leggi speciali. "Vuote anche le case Aler in convenzione"










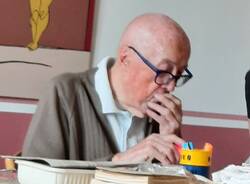




Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.