La battaglia di Legnano, una pagina di storia lombarda (e italiana)
Il 29 maggio 1176, tra Legnano e Busto, lo scontro fra gli eserciti dei Comuni della Lega Lombarda e quello dell'imperatore Federico Barbarossa, che ne uscì travolto e umiliato
 Quando parliamo della battaglia di Legnano, momento fondativo di una breve stagione di unità fra i Comuni lombardi altrimenti sempre litigiosi, andiamo a toccare un argomento spinoso, perchè deformato, nella percezione di noi contemporanei, da una serie di eventi e movimenti successivi che se ne sono ammantati, facendosene scudo e bandiera. In primo luogo fu il Risorgimento a citare questo fatto d’armi medievale nell’inno di Mameli, come ci ricorda l’ottimo Benigni di Sanremo; poi ci si mise la contemporaneità delle politica dell’Italia unita, con l’unico partito che sia posto con una certa serietà il problema di dividerla: la Lega Nord di Umberto Bossi, nata, guarda un po’, come Lega Lombarda, riprendendo il nome dall’alleanza di Comuni che sconfisse il Barbarossa, e che ha per simboli il personaggio, mitico e forse mai esistito, di Alberto da Giussano, e quel Carroccio attorno al quale si radunavano le milizie comunali. E che oggi chiede la Festa regionale il 29 maggio. Perchè c’è chi marca il territorio, e chi, non pago d’aver scostellato di scritte i muri della Padania, anche il tempo.
Quando parliamo della battaglia di Legnano, momento fondativo di una breve stagione di unità fra i Comuni lombardi altrimenti sempre litigiosi, andiamo a toccare un argomento spinoso, perchè deformato, nella percezione di noi contemporanei, da una serie di eventi e movimenti successivi che se ne sono ammantati, facendosene scudo e bandiera. In primo luogo fu il Risorgimento a citare questo fatto d’armi medievale nell’inno di Mameli, come ci ricorda l’ottimo Benigni di Sanremo; poi ci si mise la contemporaneità delle politica dell’Italia unita, con l’unico partito che sia posto con una certa serietà il problema di dividerla: la Lega Nord di Umberto Bossi, nata, guarda un po’, come Lega Lombarda, riprendendo il nome dall’alleanza di Comuni che sconfisse il Barbarossa, e che ha per simboli il personaggio, mitico e forse mai esistito, di Alberto da Giussano, e quel Carroccio attorno al quale si radunavano le milizie comunali. E che oggi chiede la Festa regionale il 29 maggio. Perchè c’è chi marca il territorio, e chi, non pago d’aver scostellato di scritte i muri della Padania, anche il tempo.
Queste premesse servano solo come avvertimento, come caveat visto che parliamo di Medioevo e bisogna ricorrere al latino, allora unica lingua internazionale (l’inglese era lingua da servi e contadini, pensate un po’), per capire che ci stiamo addentrando non tanto in un campo minato – le mine, nel XII secolo, almeno in Europa erano di là da venire – quanto in una dimensione profondamente diversa dall’attuale.
Gli antefatti non sono particolarmente gloriosi. La Lombardia nei confini attuali, allora del tutto privi di senso e nemmeno immaginati, era abitata allora da forse un milione d’anime in tutto, e più probabilmente di meno. Milano era una città in ricostruzione: quattordici anni prima l’imperatore Federico I detto il Barbarossa dopo un lungo assedio l’aveva fatta radere al suolo, ad eccezione delle chiese (era pur sempre un imperatore cristiano), con l’entusiastica partecipazione di molti lombardi che avevano alcuni conticini da saldare con i milanesi – lodigiani e comaschi in testa. Poi, stufi delle scorribande del sovrano svevo, i Comuni del Nord, quelli veneti prima, quelli lombardi poi, trovarono il modo di rinunciare alle reciproche rivalità e si unirono nel celebre Giuramento di Pontida, il 7 aprile 1167. Milano distrutta risorse con il permesso e perfino l’aiuto degli altri Comuni, impietositi – che ne stanno pagando le conseguenze da oltre otto secoli. Chiedere agli abitanti della zona di Malpensa, o ai pendolari, per informazioni.
Immaginiamo dunque di tornare indietro di questi 835 anni scarsi, fino a quel 29 maggio 1176. Cosa vedremmo intorno a noi sul campo di battaglia? Innanziutto, un paesaggio profondamente diverso dall’attuale. Una landa di brughiere qua e là coltivata, poche casupole isolate tra borghi accrocchiati intorno a una rocca e dotati, i più grossi, di sommarie mura, magari in eterna costruzione. Busto e Legnano, le "città", non dovevano avere più d’un paio di migliaia di abitanti. Non vedremmo nemmeno i boschi di oggi: le robinie, allora, semplicemente non c’erano, sono arrivate dall’America mezzo millennio dopo. Il bosco ci ricorderebbe molto di più certi angoli del Parco Ticino, per aspetto e fauna. L’assenza di strade, di case moderne e dei rumori industriali cui siamo abituati come sottofondo, e per converso la fissità del panorama della chiostra alpina, che assumiamo con buona ragione identico ad oggi nelle forme (il clima doveva essere analogo a quello odierno, tra l’altro), completano il quadro.
Se i cronisti ce l’hanno contata giusta, ed è un grosso se visto che nuovi particolari o miti da sfatare possono sempre emergere, va precisato che non siamo a Legnano; piuttosto, dalle parti di Borsano, probabilmente nella zona di Brughetto (“inter Broxanum et Bustum”, dice un conemporaneo dei fatti, Sire Raul, compilatore degli Annali Milanesi), ma la battaglia dovette svolgersi in una zona di discreta ampiezza, coinvolgendo in ogni momento un minimo di molte centinaia di armati. Il nome della battaglia richiama la città poi detta del Carroccio, vedremo perchè, in quanto da lì mosse inizialmente l’esercito della Lega. Il Barbarossa invece calava da nord, dalla Valle Olona, intenzionato a farla finita con quei dannati lombardi. Che diamine, lui, lui era l’imperatore del Sacro Romano Impero della Nazione Germanica, Re di Germania e Re d’Italia, era la quinta volta che gli toccava scendere in Lombardia e gliela avrebbe fatta vedere lui a quei pidocchiosi ribelli che le studiavano tutte per non pagare le tasse! (Gli svizzeri, in questo, ancora non c’entravano: nemmeno sapevano d’esserlo, svizzeri).
Dall’altra parte saliva l’esercito della Lega Lombarda, che, piccolo particolare, per sfuggire alla propria liigiosità si era scelta un capo comodo e lontano ma in grado di aiutare con parole e atti: Papa Alessandro III, il senese Rolando Bandinelli. Non sembri strano: allora "lombardo" significava "abitante del Nord Italia", un nord che arrivava a includere la Toscana. Fu solo dopo la fine del Medioevo, con l’ascesa delle potenze regionali di Firenze, Venezia e del Piemonte savoiardo, che il termine si restrinse ai domini milanesi.
Tornando alla battaglia, l’esercito della Lega marciava proteggendo, secondo la leggenda, un carro (il Carroccio, appunto), a quattro ruote, trainato da buoi e recante le insegne cittadine: un simbolo di uso normale fra tutti i Comuni di quella vasta "Lombardia" dell’epoca.
I lombardi in realtà non erano affatto tutti uniti. Il Barbarossa, sceso dal passo del Lucomagno e per la Valle Olona con qualche migliaio di uomini, fermandosi la notte prima dello scontro al Monastero delle Bendettine di Cairate, contava sull’appoggio dei comaschi e dei feudatari del Seprio, ed era diretto a Pavia, sua alleata nel frangente. Lo scontro avvenne in modo quasi casuale. L’esercito della Lega Lombarda contava milanesi, lodigiani, novaresi, vercellesi, piacentini, bresciani, veronesi, trevigiani.
Le avanguardie vennero in contatto, quasi casualmente, quella mattina. Nessun piano, si sa, resiste all’impatto col nemico: si tratta di battersi, ed è quello che si fece per un’intera giornata, senza risparmio di sangue, tra grida in alto tedesco e nell’antenato dei dialetti del Nord, fendenti terribili di spada, nitriti di cavalli terrorizzati, colpi di mazza a frantumare ossa, mannaie che calano su arti, lance che trafiggono interiora, sassi e frecce che volano.
All’inizio i lombardi sono più numerosi, circa in 700 contro 300, ma quando l’imperatore in persona accorre con la sua cavalleria i ribelli sono ricacciati indietro rapidamente. A questo punto il miracolo lo fa il Carroccio: le fanterie lombarde ci si aggrappano, fanno muro con scudi e lance, come un’antica falange, e resistono infliggendo le più gravi perdite agli attaccanti. Si riesce a mandare indietro dei cavalieri ad avvertire la cavalleria della Lega, rimasta verso Milano, che accorre prontamente. È la leggendaria Compagnia della Morte, 900 uomini per lo più bresciani, che ha per capitano Alberto da Giussano e ha giurato di battersi appunto fino alla morte; della storicità della compagnia e del personaggio a tutt’oggi si dibatte, essendo testimoniate solo da fonti molto più tarde del fatto d’armi. La carica comunque è irresistibile, i tedeschi e i loro alleati locali, già provati, sono travolti nella mischia: i lombardi raccolgono prigioneri di rango da riscattare a suon di quattrini, secondo l’uso dell’epoca, e lo stesso imperatore, disarcionato causando il panico fra i suoi, viene creduto morto per un pezzo prima di ricomparire, sfinito e coperto di fango, a Pavia.
L’esito, alla fine, non fu così decisivo politicamente come si può credere. Nel 1183 il Barbarossa e i Comuni sottoscrissero la Pace di Costanza, un compromesso che riconosceva la Lega Lombarda e apriva la strada all’autonomia sostanziale delle città lombarde, ma senza rimuovere il problema a monte. Le schermaglie fra i lombardi e gli imperatori tedeschi sarebbero continuate ancora a lungo, ma si era mandato un messaggio chiaro: alla prepotenza si sarebbe risposto armi in pugno.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Il pericoloso gioco alla stazione Ferno-Lonate: ragazzini attraversano i binari nel tunnel
lenny54 su È arrivato il gran giorno a Monteviasco: dopo sette anni di stop riparte la funivia
Adriana Andriani su Bogno, la Fondazione Sacro Cuore in liquidazione. Bini: "Non c'erano le condizioni economiche per proseguire"
Bruno Paolillo su Ottant’anni fa Hiroshima: la memoria della bomba che cambiò il mondo
PaoloFilterfree su Vigili del fuoco, organico solo sulla carta: Candiani denuncia l’abuso delle leggi speciali. "Vuote anche le case Aler in convenzione"
Alessandro Zanzi su Crescono le diagnosi di disabilità tra i minori di Varese: +500% in 10 anni











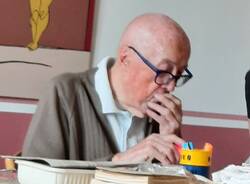




Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.